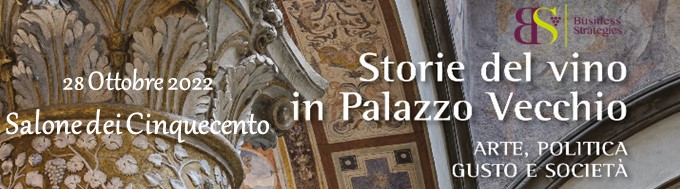Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo il comunicato in oggetto
“CONOSCERE E CURARE IL CUORE” 2025, IL PUNTO SUI TEMI D’AVANGUARDIA DELLA CARDIOLOGIA ITALIANA
VEDERE E’ POTERE. IL CONTRIBUTO FONDAMENTALE DELLE TECNICHE DI INDAGINE: IMAGING E BIOPSIA
I NUOVI TARGET: L’ICTUS CRIPTOGENETICO NEI 45ENNI; LA CARDIOMIOPATIA TRA I GIOVANI E LE NUOVE EVIDENZE A SUPPORTO DI UN APPROCCIO PRECOCEMENTE INVASIVO PER LA CURA DELL’INFARTO NSTEMI NELL’ANZIANO
OBESITA’ E MALATTIE CARDIOVASCOLARI. DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA. LE ULTIME NOVITA’
LINEE GUIDA 2024. UN NUOVO PROCESSO DI MATURAZIONE, CLASSIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CONOSCENZA IN AMBITO CARDIOLOGICO: I CASI DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE E DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
TECNICALITA’ E TECNOLOGIA SEMPRE PIU’ RAFFINATE
Firenze, 21 marzo 2025 – Quella del 2025 è la 42° edizione del congresso “Conoscere e Curare il Cuore”, anche quest’anno a Firenze dal 20 al 23 marzo a Fortezza da Basso. La fondazione Centro Lotta contro l’infarto, attraverso il congresso, mette a disposizione dei cardiologi italiani una “piattaforma di approfondimento e dibattito” sui temi più innovativi, con l’obiettivo di consolidare gli approcci terapeutici maggiormente efficaci per la salute dei pazienti. Anche quest’anno, c’è un filo rosso che lega in modo coerente parole chiave significative ad alcuni tra gli interventi più stimolanti: vedere è potere, nuovi target – i giovani e gli anziani, obesità e cuore, Linee Guida ESC, tecnicalità e tecnologie, parole che già disegnano ora le dimensioni future della cardiologia italiana e le possibilità potenziate di intervento e cura per i pazienti.
Vedere è potere. Il contributo fondamentale delle tecniche di indagine, imaging e biopsia.
La tecnologia ha fatto passi da gigante. Ed oggi ne è disponibile un livello tale da consentire diagnosi sempre più precise, come ad per esempio in relazione alla misurazione dell’infiammazione. “Se la riduzione del colesterolo LDL (low-density lipoprotein)” – commenta Francesco Prati, Presidente della Fondazione Centro per la Lotta contro l’Infarto e Direttore Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma – “rappresenta un obiettivo certo di prevenzione primaria e secondaria, il trattamento del rischio residuo infiammatorio ha una collocazione clinica più incerta. Nonostante i dubbi terapeutici, la misurazione dell’infiammazione, abitualmente espressa dal valore di hsCRP, è in grado di stratificare il rischio residuo di eventi cardiaci nei pazienti con sindrome coronarica acuta o cronica. E su questo le nuove evidenze scientifiche dimostrano che l’imaging può giocare un ruolo importante. La ricerca di segni di infiammazione locale (cardiaca) al posto di marker ematici sistemici può rappresentare uno strumento prognostico efficace. L’individuazione del tessuto adiposo epicardico si sta imponendo come una soluzione efficace anche per via della facilità con cui può essere rilevato e quantificato mediante ecocardiografia, tomografia computerizzata (CT) e risonanza magnetica per immagini (RMN). Il tessuto adiposo perivascolare sembra essere coinvolto nella stimolazione locale della formazione di placche aterosclerotiche. Correla inoltre con parametri della sindrome metabolica, tra cui l’aumento della circonferenza della vita, l’ipertrigliceridemia, l’iperglicemia ed infine l’aterosclerosi coronarica. La TC–PET con il 68Ga-DOTATATE si propone come una soluzione molto interessante in grado di discriminare lesioni coronariche ad alto rischio. Si tratta di un nuovo marcatore dell’infiammazione aterosclerotica che si lega in modo specifico a recettori dei macrofagi. Tarkin et al hanno dimostrato che il 68Ga-DOTATATE identificava in modo corretto le lesioni culprit di pazienti con sindrome coronarica acuta ed era in grado di predire la presenza di lesioni ad alto rischio secondo la valutazione CT. Tra le metodiche invasive L’OCT è l’unica con una risoluzione tale da permettere lo studio dei macrofagi. Al momento la misurazione dell’infiammazione con un indice sistemico (hsCRP) è una soluzione ragionevole. In un prossimo futuro tuttavia altri parametri ematici come l’interleuchina 6 potrebbero migliorare l’accuratezza nella diagnosi di infiammazione. È probabile che metodiche di imaging non invasivo TC o TC-PET potranno identificare meglio l’infiammazione coronarica, passando dal concetto di flogosi sistemica a quello di infiammazione d’organo”.
Vedere e potere. Il contributo fondamentale delle tecniche di indagine, imaging e biopsia.
Presente and futuro della biopsia endomiocardica nella amiloidosi cardiaca
Quanto alla biopsia, negli ultimi anni si è rivelata cruciale per l’individuazione dell’amiloidosi cardiaca (CA). L’amiloidosi cardiaca è una malattia ben riconosciuta ed è ormai diventata parte integrante delle conoscenze cliniche di tutti i cardiologi. Sebbene il sospetto di amiloidosi possa emergere in diversi ambiti specialistici, come medicina interna, ematologia, reumatologia, nefrologia e neurologia, è sempre più nell’ambito della cardiologia che vengono effettuati i primi passi diagnostici e le successive valutazioni approfondite. Infatti, la CA è una malattia che colpisce tutto il cuore, coinvolgendo il tessuto miocardico, le valvole, i vasi e l’epi-pericardio, con implicazioni cliniche per le miocardiopatie, l’insufficienza cardiaca (HF) – in particolare l’insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata (HFpEF) – la malattia calcifica della valvola aortica, la cardiopatia coronarica e i disturbi del ritmo. Paradossalmente, il numero globale di biopsie endomiocardiche (EMB) è aumentato nell’ultimo decennio, nonostante la disponibilità di strumenti diagnostici alternativi. La crescente “consapevolezza” e la nuova epidemiologia della CA – particolarmente dell’ATTRwt- hanno portato all’istituzione di programmi diagnostici focalizzati sulle EMB. La crescente consapevolezza della CA e l’aumento del tasso di rilevamento della CA da ATTRwt nei pazienti anziani hanno posizionato l’EMB come un potenziale strumento di screening per pazienti con fenotipo HFpEF o per pazienti con ipertensione, ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) e scompenso cardiaco di eziologia sconosciuta. L’uso dell’EMB è destinato ad espandersi in diversi scenari clinici, tra cui i seguenti: diagnosi precoce nell’amiloidosi ATTRv familiare; scompenso cardiaco di eziologia sconosciuta; amiloidosi iatrogena sistemica; rilevazione incidentale di amiloidosi in campioni di tessuti non cardiaci; aritmie; malattia calcifica della valvola aortica.
I nuovi target. l’ictus criptogenetico: troppi indiziati per trovare un colpevole? sempre più frequente nella popolazione sotto i 45 anni
Con l’evoluzione della tecnologia, emerge la possibilità di indagare con maggior precisione e rilevare nuove evidenze e target. E’ il caso dell’ictus criptogenetico che, come indica il nome stesso è ancora criptico, ha troppi indiziati per trovare una causa ed è sempre più frequente nella popolazione sotto i 45 anni. L’ictus cerebri – di origina sia ischemica che emorragica – rappresenta un problema evidente per la sanità pubblica, l’individuo affetto e le famiglie del medesimo. Secondo il Ministero della Salute ed i dati pubblicati dall’alleanza cardio-cerebrovascolare, in Italia l’ictus segue solo alla cardiopatia ischemica come causa di morte, risultando responsabile del 10% circa di tutti i decessi. Ogni anno si registrano in Italia poco meno di 100.000 ricoveri per ictus cerebri, di cui circa il 20% è rappresentato da recidive. Il 20-30% delle persone colpite da ictus cerebrale muore entro un mese dall’evento, il 40-50% entro il primo anno. Solo il 25% dei pazienti sopravvissuti ad un ictus guarisce completamente, mentre ben il 75% sopravvive, ma con una qualche forma di disabilità. Di questi sopravvissuti con disabilità, circa il 50% risulta essere portatore di un deficit talmente grave da implicare la perdita dell’autosufficienza. L’ictus cerebri è una entità disomogenea. Questo non solo per quanto attiene la morfologia e la dimensione dell’area lesa, che può essere minuscola come enorme, bensì anche per origine. Circa 9 ictus su 10 sono ischemici, mentre i rimanenti sono emorragici. Tra gli ictus ischemici, quasi un quarto – spesso originante da piccoli vasi – sono di tipo lacunare. Tra i non lacunari, estremamente comune è l’ictus cardioembolico, ma soprattutto – forse sorprendentemente – quello di origine ignota. Malgrado questo, un ictus criptogenetico può avere tanti indiziati e, non di rado, finire con nessun colpevole. Partendo dalla definizione, le Linee Guida dell’American Heart Association e dell’American Stroke Association per la prevenzione dell’ictus in pazienti reduci da un ictus o TIA definiscono l’ictus criptogenetico come un ictus confermato e dimostratamente di origine ignota dopo aver effettuato almeno un imaging accurato, un ecocardiogramma, un monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco e gli esami di laboratorio chiave, quali il profilo lipidico e l’emoglobina glicosilata. Le cause da investigare, in particolare, sono numerose: pervietà del forame ovale; fibrillazione atriale occulta; trombofilia; ateromasia aortica; tumori cardiaci; dissezione arteriosa la quale, nella popolazione generale, è causa di ictus ischemico in non più del 2% dei casi. Limitando però l’attenzione ai pazienti più giovani (<50 anni), questa percentuale può salire fino al 25%. L’età media alla diagnosi è intorno ai 45 anni ed è in genere anticipata lievemente tra le donne, che però manifestano meno comunemente degli uomini questa patologia; neoplasie non cardiache; patologie infiammatorie coinvolgenti i grandi, medi e piccoli vasi.
Nuovi target: espressioni fenotipiche e manifestazioni cliniche della cardiomiopatia aritmogena. un fenomeno diffuso anche tra i giovani
Quanto ai giovani, in minoranza certo, si riscontra il dolore toracico quale sintomo d’esordio della cardiomiopatia aritmogena. La cardiomiopatia aritmogena (CMA) è una patologia del miocardio caratterizzata da alterazioni strutturali e funzionali dei cardiomiociti, associate ad una maggiore predisposizione per aritmie ventricolari maligne e morte cardiaca improvvisa (MCI). Storicamente, la CMA era rappresentata dalla cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (CMA-VD), una forma che coinvolge primariamente il ventricolo destro (VD) con dilatazione, disfunzione e/o alterazioni della cinetica parietale associate ad aritmie ventricolari maligne ad origine dal VD. La diffusione nella pratica clinica della risonanza magnetica cardiaca (RMC) con mezzo di contrasto e dell’analisi genetica ha contribuito a una comprensione più ampia di questa patologia, con evidenza di sostituzione fibrotica o fibro-adiposa del miocardio in entrambi i ventricoli e di una sovrapposizione clinica e genetica tra le cardiomiopatie del ventricolo sinistro (VS) e VD. La CMA può presentarsi con un ampio spettro di manifestazioni cliniche, che vanno dalle aritmie allo scompenso cardiaco e possono variare in base al grado di coinvolgimento ventricolare, alla progressione della malattia, al substrato genetico ed altri fattori ancora non del tutto compresi. Da un lato, nella fase iniziale o subclinica, il paziente affetto da CMA può essere totalmente asintomatico, con una diagnosi incidentale, talvolta grazie allo screening clinico e genetico in soggetti con una storia familiare positiva. Già in questa fase le alterazioni elettrocardiografiche possono essere presenti (bassi voltaggi, onde T negative, extrasistolia ventricolare frequente) e rappresentare campanelli d’allarme per l’avvio di un iter diagnostico approfondito, che trova nella caratterizzazione tissutale della RMC la possibilità di identificare precocemente sostituzione fibrosa o fibro-adiposa ventricolare. Dall’altro lato le aritmie ventricolari possono essere la prima manifestazione di malattia. Le aritmie possono presentarsi sotto forma di cardiopalmo ed episodi di sincope o pre-sincope e possono essere indotte dallo sforzo fisico. Con la progressione della malattia, il coinvolgimento strutturale del miocardio diventa più evidente e la sostituzione fibrosa o fibro-adiposa, inizialmente localizzata, può estendersi a forme biventricolari (BiV), accentuando la dilatazione e la disfunzione ventricolare, sia destra che BiV. Questi cambiamenti si possono associare ai segni e sintomi classici di scompenso cardiaco, con possibile evoluzione verso lo scompenso cardiaco avanzato. In una minoranza di pazienti, più spesso giovani, il dolore toracico può rappresentare il sintomo d’esordio.
Nuovi target: terapia dell’infarto NSTEMI nell’anziano: il Senior-rita trial, nuove evidenze a supporto di un approccio precocemente invasivo
L’infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) ha caratteristiche ben definite all’interno del quadro delle Sindromi Coronariche Acute (SCA). Fin dalle prime definizioni prospettiche della sindrome, rispetto ai pazienti con STEMI, quelli con NSTEMI si sono caratterizzati per essere più anziani, con una maggiore prevalenza di determinanti di rischio a lungo termine, quali diabete e insufficienza renale, pregresso infarto e rivascolarizzazioni, e con una coronaropatia più estesa. Queste caratteristiche differenziali persistono anche nella popolazione ottuagenaria, come dimostrato dai dati comparativi dei pazienti con STEMI e NSTEMI reclutati negli studi dedicati ai pazienti anziani con SCA. Per tali motivi, nel lungo termine lo NSTEMI è stato finora considerato una sindrome a prognosi peggiore rispetto allo STEMI. Nel NSTEMI la trombolisi non risolve il quadro clinico, e anche la dimostrazione di una superiorità della rivascolarizzazione, rispetto alla terapia medica, è stata molto problematica: mentre per ogni 100 coronarografie in corso di STEMI almeno 90 esitano in rivascolarizzazione immediata, nel NSTEMI solo la metà dei pazienti sottoposti a coronarografia riceveranno rivascolarizzazione, e questo anche negli studi più recenti, il 49.9% nel recente SENIOR-RITA (Older Patients with Non–ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Randomized Interventional Treatment) trial. Per questi motivi, il percorso verso la dimostrazione di una superiorità di una strategia precocemente invasiva con angiografia e, laddove fattibile, rivascolarizzazione nel paziente anziano con NSTEMI, iniziata nel 2008 con l’Italian Elderly ACS trial è stato molto complesso. In tale contesto va inserito il SENIOR-RITA trial condotto nel Regno Unito tra il 2016 e il 2023 e interrotto leggermente prima del previsto numero di 1668 pazienti, anche per l’intercorrente pandemia che ha inevitabilmente rallentato l’arruolamento nei 48 centri partecipanti. Circa un quinto dei 6977 pazienti eleggibili sono stati randomizzati, con un totale di 1518 partecipanti. Lo studio ha molti aspetti encomiabili: ha arruolato solo pazienti con type 1 NSTEMI, eliminando il rumore di fondo del NSTEMI secondario a cause emodinamiche, ipertensive o aritmiche (type 2); non ha escluso dall’arruolamento i pazienti fragili e quelli con co-patologie o deterioramento cognitivo, conducendo in tutti i pazienti un’ importante valutazione multifunzionale che sarà patrimonio per successive analisi sull’impatto prospettico di queste condizioni prevalenti nei pazienti anziani; non ha escluso i pazienti con indicazione a terapia anticoagulante che hanno costituito circa il 23% della popolazione; l’89% delle procedure è stato condotto con accesso radiale con complicanze procedurali in meno dell’1% dei pazienti. I risultati, mostrano che solo i rischi di reinfarto e successiva rivascolarizzazione si sono ridotti significativamente con l’approccio invasivo, confermando i dati della precedente metanalisi. Nello studio SENIOR RITA, l’endpoint primario composito di morte cardiovascolare e infarto non fatale mostra un trend molto favorevole con l’approccio invasivo nei pazienti di età <80 anni, a fronte di un risultato decisamente neutro in quelli di età >80.
Obesita’ e malattie cardiovascolari. Due facce della stessa medaglia. Le ultime novità.
Il cardiodiabetologo: non è solo una questione di glicemia
I nuovi farmaci antiobesità hanno avuto la capacità di rilanciare e trasformare il ruolo del cardiologo, ora un cardiodiabetologo, che ha in carico la valutazione di tutto l’assetto cardiometabolico del paziente. Infatti, la gestione clinica dei pazienti con T2D si è evoluta notevolmente nell’ultimo decennio. Le strategie di riduzione intensiva del glucosio avevano fino ad allora sostanzialmente fallito nel ridurre in maniera convincente morbilità e mortalità cardiovascolari, sebbene una metanalisi di tutti gli studi avesse suggerito un modesto beneficio in termini di riduzione dell’infarto miocardico non fatale. Tale sostanziale fallimento ha portato per anni alla percezione tra i cardiologi che il controllo di altri fattori di rischio cardiovascolare, quali la pressione arteriosa e il colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C), fossero le sole importanti misure efficaci nel ridurre il rischio cardiovascolare nel T2D. Recentemente, tuttavia, diversi studi clinici di esito su larga scala con nuovi farmaci ipoglicemizzanti quali gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 e gli agonisti del recettore del peptide di tipo 1 simil-glucagone hanno dimostrato una robusta e significativa riduzione degli eventi avversi cardiovascolari maggiori (major adverse cardiovascular events, MACE). Gli effetti positivi in termini di sicurezza ed efficacia sulle misure di esito cardiovascolare sono risultate in entrambi i casi, peraltro, ampiamente indipendenti dalle proprietà ipoglicemizzanti di questi farmaci. Pertanto i risultati di questi studi clinici randomizzati hanno modificato in maniera sostanziale il paradigma di trattamento dei pazienti con T2D, spostando l’attenzione dal semplice controllo glicemico all’intervento “cardio-metabolico”, con indicazioni ora date per la riduzione del rischio cardiovascolare per tre degli SGLT2i (empagliflozin, canagliflozin e dapagliflozin) e per tre GLP-1 RA (liraglutide, dulaglutide e semaglutide) negli Stati Uniti, in Europa, e in molti altri paesi. Numerose sono le evidenze da studi clinici relativi agli effetti cardioprotettivi degli inibitori di SGLT2 e degli agonisti del recettore GLP-1. Una metanalisi del 2021 di sei studi clinici randomizzati ha valutato la sicurezza e l’efficacia degli SGLT2i in soggetti con T2D sia ad alto rischio che con malattia cardiovascolare aterosclerotica conclamata. Tale metanalisi ha dimostrato che complessivamente gli SGLT2i erano associati a un ridotto rischio di eventi cardiovascolari avversi maggiori, quali morte cardiovascolare, infarto miocardico e ictus. In tale metanalisi è emerso come la presenza o l’assenza di malattia cardiovascolare aterosclerotica non modifichi l’associazione di efficacia del trattamento sui MACE. Relativamente a ciascun componente dei MACE, inoltre, gli SGLT2i riducono significativamente il rischio di morte cardiovascolare e la mortalità per tutte le cause, ma non il rischio di ictus. Sebbene ad oggi gli SGLT2i e i GLP-1 RA abbiano diverse indicazioni di classe 1 per la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari in diverse linee guida e raccomandazioni di società internazionali, il loro utilizzo cardiologico è ancora, e ingiustificatamente, inferiore al loro potenziale. Sono stati identificati diversi ostacoli alla reticenza prescrittiva da parte dei cardiologi, e quindi proposti interventi per ottimizzare l’adozione di terapie preventive cardiovascolari. L’impiego di questi farmaci cosiddetti cardio-metabolici è alla base della recente evoluzione concettuale che li considera non più solo agenti ipoglicemizzanti, ma farmaci ad azione pleiotropica con importanti effetti di riduzione del rischio cardiovascolare. Questa riduzione del rischio si esplica non solo nel contesto dei soggetti diabetici come prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, ma anche nell’ambito degli stati disglicemici che precedono lo sviluppo di diabete conclamato. Nel caso degli SGLT2i gli effetti sullo scompenso cardiaco appaiono indipendenti anche dalla situazione di pre-diabete. Tale assunto è essenziale per comprendere che essi rappresentino una pietra miliare dell’armamentario terapeutico contemporaneo che il cardiologo deve conoscere e impiegare pienamente in maniera del tutto complementare e indipendentemente dai diabetologi.
Obesita’ e malattie cardiovascolari. Due facce della stessa medaglia. Le ultime novità.
Il punto sull’obesità: rischio cardiovascolare e novità terapeutiche
Negli ultimi anni un crescente numero di evidenze ha dimostrato uno stretto legame tra obesità (body mass index [BMI] ≥30 kg/m2) e rischio cardiovascolare. Ne è poi emerso il concetto di “sindrome cardiovascolare-renale-metabolica” (CKM), definita come condizione patologica derivante da interazioni tra obesità, diabete mellito di tipo 2 (T2DM), malattia renale cronica (CKD) e malattia cardiovascolare (CVD; tra cui scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, malattia aterosclerotica coronarica, stroke e malattia arteriosa periferica), e che include sia i pazienti a rischio di CVD, che quelli con CVD conclamata. Di recente, l’American Heart Association ha proposto uno staging “fisiopatologico” della CKM, identificando come stadio iniziale (stadio 1) la presenza di tessuto adiposo o “adiposità” in eccesso (per BMI ≥25 kg/m2 o obesità viscerale) oppure disfunzionale (per ridotta tolleranza al glucosio o stato di prediabete). Tale adiposità conduce progressivamente alla insorgenza di fattori di rischio metabolici quali dislipidemia, ipertensione arteriosa, diabete e/o CKD (stadio 2) per poi portare alla malattia cardiovascolare subclinica o alla presenza di equivalenti di rischio (stadio 3), fino ad arrivare alla malattia cardiovascolare clinicamente conclamata (stadio 4). L’adiposità in eccesso o disfunzionale rappresenta dunque il fattore fisiopatologico chiave delle conseguenze multi-sistemiche della CKM, che vede negli eventi cardiovascolari e nella mortalità cardiovascolare il suo outcome clinico più significativo. Il trattamento farmacologico della obesità viene raccomandato per BMI ≥30 kg/m2, oppure ≥27 kg/m2 in presenza di una o più comorbidità ad essa correlate. Ad oggi risultano approvati sei farmaci per la gestione a lungo termine della obesità non sindromica: orlistat, fentermina/topiramato, naltrexone/bupropione, gli agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1 RA) liraglutide 3 mg sottocute (sc.) e semaglutide 2.4 mg sc., e l’agonista duale del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente / recettore del peptide-1 simile al glucagone (GIP/GLP-1) tirzepatide 5-15 mg sc. Tali molecole portano a un calo ponderale e ad un miglioramento dei parametri metabolici con potenza ed effetto variabili e, tra queste, semaglutide 2.4 mg sc. e tirzepatide 5-15 mg sc. hanno dimostrato la maggiore efficacia. La semaglutide rappresenta il GLP-1 RA più efficace nella riduzione del peso corporeo, nonché l’unica molecola ad avere ad oggi dimostrato, grazie allo studio SELECT, una riduzione significativa del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da obesità, non diabetici e con malattia cardiovascolare preesistente. I risultati dello studio SELECT hanno la potenzialità per rappresentare un punto di svolta nella pratica clinica e per condizionare una ricaduta notevole in termini di riduzione della morbidità e mortalità cardiovascolare nell’ambito della prevenzione secondaria. Inoltre, insieme a tirzepatide, trova potenzialità anche nel fenotipo di HFpEF relato alla obesità, avendo dimostrato di potere ridurre il rischio di scompenso cardiaco “worsening” in un ambito dove vi è da sempre una paucità di trattamenti efficaci. Nel futuro, sarà sicuramente da valutare l’impatto sugli outcome cardiovascolari-renali-metabolici della terapia di associazione con GLP-1 RA e SGLT2-i. Nel mentre, rimaniamo in attesa di vedere come le agenzie regolatorie del farmaco e le linee guida internazionali recepiranno le evidenze di semaglutide e tirzepatide nel setting specifico della obesità e del rischio cardiovascolare.
Linee guida 2024. Un nuovo processo di maturazione, classificazione e consolidamento della conoscenza in ambito cardiologico: i casi della fibrillazione atriale e della cardiopatia ischemica cronica
Aggiornamento delle linee guida ESC 2024 in relazione alla fibrillazione atriale
Le linee guida ESC 2024 sulla fibrillazione atriale (FA) sono state sviluppate per fornire ai professionisti sanitari raccomandazioni aggiornate, basate sull’evidenza e integrate con il parere degli esperti, al fine di supportare una diagnosi e una gestione efficaci della FA. Queste linee guida mirano ad aiutare i clinici a personalizzare gli approcci diagnostici e terapeutici in base alle esigenze specifiche di ogni paziente, tenendo conto del loro profilo clinico e delle eventuali comorbidità. Le linee guida ESC 2024 pongono un forte accento sulla gestione delle comorbidità e sul controllo dei fattori di rischio, considerandoli strategie fondamentali sia per la prevenzione primaria che per quella secondaria della FA. Questo approccio olistico sottolinea come il controllo delle condizioni sottostanti non sia solo cruciale per ridurre il carico della FA, ma anche per prevenire le recidive della patologia. In questo contesto, l’ablazione della fibrillazione atriale viene identificata come un intervento importante, che deve essere integrato in una strategia terapeutica più ampia e multifattoriale. Le linee guida non considerano l’ablazione come un trattamento isolato, ma ne incoraggiano l’uso come parte di un piano terapeutico personalizzato, che tenga conto di tutti gli aspetti dell’assistenza al paziente. Questo approccio evidenzia il valore dell’ablazione come un elemento chiave nel complesso mosaico della gestione della FA. Nonostante un ampio corpo di letteratura pubblicato negli ultimi 4 anni sull’ablazione dell’AF (fibrillazione atriale), ci sono solo pochi aggiornamenti nelle linee guida (GL) del 2024 rispetto a quelle del 2020. È stata introdotta una nuova indicazione per l’ablazione dell’AF per evitare l’impianto di pacemaker nei pazienti con bradicardia correlata all’AF o pause sinusali dopo la cessazione dell’AF. Questa raccomandazione si basa tuttavia sul consenso degli esperti e non su studi clinici randomizzati. Le linee guida ora includono una nuova raccomandazione per le procedure di nuova angioplastica nei pazienti sintomatici che hanno già subito un’ablazione. Questo aggiornamento è supportato da dati emergenti, anche se alcuni studi riportano discrepanze sull’efficacia dell’ablazione ripetuta nel ridurre significativamente le recidive di AT/AF. Attualmente, non ci sono raccomandazioni definitive riguardo alla tecnica ottimale per l’ablazione dell’AF persistente. Questa mancanza di orientamenti chiari sottolinea la necessità di ulteriori ricerche e studi randomizzati ben progettati per definire meglio il ruolo di queste tecniche e identificare le strategie più efficaci per l’ablazione dell’AF sia parossistica che persistente. Le linee guida delle società professionali vengono aggiornate periodicamente per riflettere i progressi nel campo. Tuttavia, la metodologia attuale per questi aggiornamenti introduce inevitabilmente un ritardo, impedendo alle linee guida di incorporare tempestivamente nuove evidenze che potrebbero cambiare la pratica. Questa latenza deriva dai processi strutturati e spesso lunghi necessari per esaminare, valutare e adottare formalmente gli aggiornamenti. Anche se è stata pubblicata una quantità significativa di letteratura sull’ablazione dell’AF utilizzando diverse fonti di energia, tra cui radiofrequenza, crioablazione, e la più recentemente introdotta ablazione a campo pulsato, le attuali linee guida non esprimono una chiara preferenza né forniscono indicazioni specifiche per alcuna tecnica particolare. Mancano, infatti, indicazioni sulle fonti di energia e strategie aggiuntive oltre all’ablazione delle vene polmonari, creando una discrepanza tra le raccomandazioni delle linee guida e le procedure reali effettuate.
Linee guida 2024. Un nuovo processo di maturazione, classificazione e consolidamento della conoscenza in ambito cardiologico: i casi della fibrillazione atriale e della cardiopatia ischemica cronica
Cosa è cambiato nella gestione della cardiopatia ischemica cronica? Le nuove linee guida ESC 2024
La cardiopatia ischemica è tra le principali cause di mortalità e morbidità nel mondo, e la gestione delle sue diverse manifestazioni continua a rappresentare un importante focus della ricerca scientifica. Già nel 2019 le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) hanno sostituito il termine di “angina stabile” con quello di “sindrome coronarica cronica” (SCC), a sottolineare il carattere progressivo di una patologia con uno spettro di manifestazioni cliniche eterogeneo. Le nuove linee guida ESC del 2024 per la diagnosi ed il trattamento delle SCC riflettono questo cambio di paradigma e affrontano la gestione del paziente con SCC nell’insieme delle diverse manifestazioni cliniche della coronaropatia, che comprende la malattia dei vasi epicardici, dei vasi di medio calibro e del microcircolo, includendo sia le alterazioni anatomiche, che i disturbi funzionali. Viene inoltre rivisitata la stratificazione del rischio di malattia coronarica e sviluppata una nuova “carta del rischio” finalizzata alla scelta del più appropriato test diagnostico di secondo livello. Infine, le nuove linee guida ESC del 2024 affrontano le strategie terapeutiche per la gestione del paziente con SCC utilizzando un approccio di “medicina personalizzata”, basato sull’impostazione di una terapia mirata al preciso meccanismo fisiopatologico alla base delle manifestazioni cliniche della coronaropatia. Un elemento di novità delle ultime linee guida sulla diagnosi ed il trattamento delle SCC è rappresentato dall’impiego di un work-up diagnostico che preveda la stima della probabilità del rischio di coronaropatia ostruttiva sulla base dell’integrazione della valutazione clinica e della presenza di fattori di rischio cardiovascolari. In seguito a tale valutazione si procede ad eseguire il test diagnostico più accurato per la probabilità pre-test stimata. Le nuove linee guida ESC propongono pertanto l’incorporazione dei fattori di rischio cardiovascolari (abitudine tabagica, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, familiarità per malattie cardiovascolari) nella valutazione della probabilità pre-test del paziente, fornendo un modello che consente di stratificare il rischio in: molto basso (≤5%), basso (5-15%), moderato (15-50%), elevato (50-85%) e molto elevato (>85%). Il vantaggio di questo approccio, specialmente se integrato con il calcolo del “calcium score” (CS), risiede nella sua accuratezza fino a tre volte superiore rispetto ai precedenti sistemi nel re-classificare i pazienti con rischio “basso” in “molto basso”, con un potenziale significativo risparmio di risorse e riduzione del tasso di coronarografie inappropriate. E’ da ricordare tuttavia che il modello proposto dalle linee guida ESC 2024 non comprende alcuni fattori di rischio o comorbidità che si associano ad un aumentata probabilità di sviluppare malattia coronarica, quali l’ipercolesterolemia familiare, l’insufficienza renale, le patologie infiammatorie sistemiche o l’arteriopatia degli arti inferiori, che vanno tuttavia considerati. Un’ulteriore limitazione dell’approccio proposto è che non consente di stratificare il rischio di malattia coronarica legata a patologia funzionale dei vasi epicardici o del microcircolo. Per tale gruppo di individui, un’accurata anamnesi e l’esperienza del clinico rimangono i principali strumenti a disposizione prima dell’esame angiografico invasivo. In conclusione, le linee guida ESC 2024 per la diagnosi ed il trattamento delle SCC offrono un approccio olistico e personalizzato nella gestione del paziente con SCC, rivisitando la stratificazione del rischio di probabilità di malattia coronarica, sottolineando l’importanza di uno studio angiografico completo e di un approccio di medicina personalizzata, mirato all’impostazione di una terapia farmacologica specifica per il preciso meccanismo fisiopatologico di malattia.
Tecnicalità e tecnologia sempre più raffinate.
Il progetto Revolution: la pianificazione e l’esecuzione della rivascolarizzazione chirurgica basata esclusivamente sulla CT coronarica
L’Angiografia tomografica computerizzata coronarica (TAC) è una tecnica diagnostica non invasiva sempre più utilizzata in alternativa all’angiografia coronarica (AC) nei pazienti con sospetta malattia coronarica, in grado di fornire importanti informazioni sulla sua estensione e gravità. Inoltre recentemente sono stati introdotti nella pratica clinica nuovi strumenti per la valutazione funzionale delle stenosi coronariche mediante TAC, quali la perfusione miocardica da stress (CT-MPI) e la riserva di flusso frazionaria (CT-FFR). L’AC è stata la metodica diagnostica preferita per guidare il processo decisionale tra rivascolarizzazione chirurgica (CABG) e percutanea (PCI). Recentemente due studi hanno indagato la fattibilità dell’utilizzo della TAC in sostituzione dell’AC nella pianificazione del CABG. Lo studio SYNTAX III REVOLUTION ha dimostrato che la scelta del tipo di rivascolarizzazione (CABG o PCI) basata sull’analisi della TAC aveva un alto livello di concordanza con le decisioni basate sull’analisi dell’AC nei pazienti affetti da malattia trivasale e/o con coinvolgimento del tronco comune. Nello studio FASTTRACK la procedura di CABG pianificata mediante l’esecuzione della sola TAC risultava essere fattibile e con un accettabile profilo di sicurezza in una specifica popolazione di pazienti affetti da malattia coronarica complessa. Questi risultati, seppur intriganti e promettenti, necessitano tuttavia di una validazione mediante studi randomizzati adeguatamente dimensionati volti a confrontare le due strategie.
Tecnicalità e tecnologia sempre più raffinate.
I risultati a 5 anni del pacemaker leadless: buone notizie?
Negli ultimi 10 anni, la terapia con i pacemaker leadless ha superato la fase sperimentale ed è divenuta un’opzione terapeutica consolidata. È ormai disponibile una consistente mole di dati, anche con follow up di media lunghezza, che suggeriscono che i PM leadless VVI(R) monocamerali sono associati a poche infezioni e meno complicazioni complessive, in particolare a lungo termine, rispetto ai pacemaker transvenosi. Le perforazioni acute possono essere più frequenti e gravi, ma il loro rischio si riduce con il training e la maggiore esperienza degli operatori. L’introduzione della stimolazione VDD(R) e, più di recente, DDD(R), ha ampliato l’area di indicazione di questi dispositivi a un numero notevolmente maggiore di pazienti. Costi elevati, esperienza di sostituzione limitata e mancanza di studi randomizzati attualmente ne limitano ancora l’adozione diffusa. Tuttavia, per molti pazienti, come quelli sottoposti a emodialisi, con accesso vascolare limitato o con un rischio elevato di endocardite, il PM leadless rappresenta già la prima scelta terapeutica.
Fonte: Ufficio Stampa